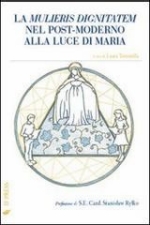a cura di Laura Tortorella, IF Press, Morolo (FR), 2012, pp. 252 (“Essay Research Series” 10).
Il testo si presenta come una raccolta di contributi che, da molteplici prospettive, offrono una lettura dell’unidualità uomo-donna a partire dagli spunti e dalle indicazioni del celebre documento pontificio Mulieris Dignitatem, consegnato alla Chiesa da Giovanni Paolo II durante l’anno Mariano straordinario, il 15 agosto 1988.
Oltre la pregevole prefazione redatta dal card. S. Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, il testo – curato dalla professoressa Laura Tortorella, docente presso la nostra Facoltà s. Bonaventura – si segnala, perfino nella sua struttura, come il frutto di una collaborazione a più mani tra uomini e donne. I vari articoli, infatti, sono quasi tutti frutto di una comune stesura da parte di due autori, un uomo e una donna appunto; quando invece l’articolo è di un solo autore, esso è sempre preceduto e seguito da un contributo redatto da un esperto dell’altro sesso. Gli autori degli articoli, nell’ordine in cui compaiono nella miscellanea, sono: mons. Josef Clemens, Rita Torti, p. Dihn Anh Nhue Nguyen, Mario Stella e Giorgia Salatiello, p. Roberto Tamanti e Paola Mancinelli, p. Gianfranco Grieco e Emanuela Vinai, p. Raffaele Di Muro e sr. Teresa Benedetta Di Muro, Ana Cristina Villa Betancourt e mons. Antonio Grappone, Laura Tortorella e Rafael Nava Ureña, Pasquale Laselva e Maria Beatrice Toro, Oreste Bazzicchi e Laura Viscardi Gentili, Pina Cataldo, Nicola Ferrante e, infine, Maria Marcellina Pedico.
La scelta di questo approccio sinfonico tra maschile e femminile svela il desiderio di affrontare il tema del gender – particolarmente delicato e controverso proprio nel nostro contesto culturale occidentale – a partire da quella consapevolezza, espressa con chiarezza dall’agiografo attraverso l’affermazione, posta sulle labbra del Creatore nel libro della Genesi, : «non è bene che l’uomo sia solo» (Gen 2,18). Alla luce della fede, infatti, non è possibile parlare dell’uomo senza la donna, né della donna senza l’uomo, perché l’uomo e la donna sono persone, esseri-per-la-comunione, e solo nella comunione personale nell’amore raggiungono la pienezza di quella verità antropologica e teologica che è promessa nell’evento creatore ma che è realizzata pienamente nella Pasqua di Cristo. Non a caso, come ben sappiamo, la lettera agli Efesini svela il vero senso dell’amore coniugale nella comunione realizzata nella Pasqua tra Cristo e la sua Sposa, la Chiesa: «Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!» (Ef 5,31-32).
In questo senso è significativo il riferimento – anche come fonte filosofico-teologica – alla riflessione sulla persona e sull’amore come sua verità nel pensiero di Karol Wojtyla, in opere come Amore e responsabilità, Paternità-maternità e la «communio personarum», nonché nel suo magistero sull’amore e sulla teologia del corpo. È reso accessibile così e comprensibile l’unità di tutto il discorso sull’identità personale (che è sessuata) e sull’affettività nel contesto della rivelazione e dell’accoglienza della fede, comprese come apertura e porta di ingresso verso il pieno sviluppo della propria umanità, singolare e comunitaria. Afferma infatti la Curatrice:
Come soluzione al […] possibile sconvolgimento del vero significato del matrimonio, il Cardinale polacco consiglia “(…) una certa purificazione spirituale, purificazione nella sfera delle idee, dei valori, dei sentimenti e delle azioni. La morale cristiana nel campo delle questioni del sesso e del corpo è organicamente legata alla benedizione per gli uomini «puri di cuori perché vedranno Dio» (Mt 5,8)” (p 170-171).
Accennavamo alla compresenza di molteplici approcci epistemologici al tema: troviamo, infatti, contributi che affrontano l’argomento dal punto di vista della teologia biblica, da quello dellaantropologia filosofica e teologica, della teologia morale e spirituale, della psicologia e della sociologia e dello studio dei mezzi di comunicazione di massa.
Ogni articolo però manifesta allo stesso tempo la costante attenzione di voler entrare in dialogo con la cultura contemporanea e di essere a servizio di una prassi che sia sempre più ispirata e animata dall’accoglienza della Rivelazione biblica, soprattutto mediante la mediazione del magistero pontificio recente, e in particolare di Mulieris Dignitatem.
Il paradigma femminile, dunque, nell’originale lettura condotta dalla MD sulla figura di Maria di Nazareth diventa cifra ermeneutica di significato antropologico, teologico ed ecclesiologico che invia ad ulteriori indagini verso nuovi approfondimenti che pur fondano la loro istanza prima nel dettato biblico della creazione (p. 252).
In particolare – facendo proprio riferimento a questa lettera apostolica di Giovanni Paolo II – la figura di Maria, vergine e Madre di Dio, è presentata, in particolare nel contributo conclusivo, per mano di M. M. Pedico, come la donna perfetta, vergine, madre, sposa, ma allo stesso tempo come la pienezza – nella sua unicità – dell’umanità creaturale tout court, perché tutta disponibile all’accoglienza e all’azione della grazia.
Giovanni Paolo II fonda, sviluppa e prospetta «la verità sulla donna» alla luce del mistero di Cristo, là dove afferma che se è il Cristo a svelare pienamente l’uomo all’uomo, allora è anche vero che «in questo svelare l’uomo all’uomo […] bisogna scoprire un posto particolare per quella donna che fu Madre di Cristo» (MD 2). […] Il dialogo dell’Annunciazione fa emergere inoltre Maria come prototipo di ciò che caratterizza la persona umana: il suo stesso atteggiamento davanti al suo Signore diventa paradigmatico di ogni altro rapporto di unione tra l’uomo e Dio (p. 244-246).
Concludendo, non possiamo che auspicare che opere di questo tipo arricchiscano sempre più il panorama della riflessione teologica contemporanea. In modo particolare, sarebbe desiderabile riuscire a elaborare un pensiero e un’articolazione della riflessione che – pur tenendo conto delle diverse competenze e sensibilità dei singoli esperti – assuma dei tratti sempre più comunitari, corali, che contribuisca cioè a mostrare come la forza e il contributo precipuo del pensiero ecclesiale sia anzitutto la sua origine e il suo fine, che è la comunione personale in Cristo per opera dello Spirito santo nella Chiesa, per la salvezza del mondo (cf. Gv 3,17): finché «Dio sia tutto in tutti» (1Cor 15,28).
Giulio Cesareo OFMConv