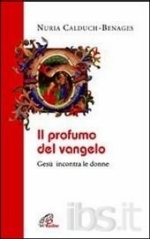Un libro coinvolgente fin dal titolo, con la proposta di un qualcosa di così estremamente immateriale, ma, di fatto, così concretamente percepibile come il profumo e l’Autrice, in effetti, sa cogliere quel sentore d’arcano, questo, che noi, con il suo permesso, vorremmo chiamare «profumo di donna», nel quale Gesù di Nazaret, il Cristo, non disdegna di farsi coinvolgere, in incontri, caratterizzati da un interscambio nel quale le une e l’Altro arrivano gradatamente a comporre il quadro della rispettiva identità.
Dunque un «profumo di donna» che l’Autrice percepisce e, si potrebbe dire per rimanere nella metafora, riesce ad annusare e, come un profumiere di classe, scomporre nei suoi elementi, descrivendoli fin nelle minuzie per sollecitare il senso del lettore ad un’altra lettura. E tutta questa operazione è condotta con la valentia propria del vero artigiano - vorremmo dire artista, se tale termine potesse risultare non ambiguo per la teologia – nel senso che l’Autrice, come un vero artigiano, procede nella composizione della propria opera non solo con le sue personali intuizioni e convinzioni, ma anche con quelle dei propri predecessori e maestri, cosicché possiamo contare su una bibliografia vasta ed eterogenea; vasta, in quanto ben dieci pagine dell’intera opera, centoquarantatotto in tutto, sono dedicate alla bibliografia, ed eterogenea perché va dalle più antiche fonti della fede, della filosofia e teologia cristiana ai teologi cattolici più moderni, dai teologi protestanti ai pensatori ebrei, fino alle teologhe protestanti di stampo più marcatamente femminista .
Con tutto questo bagaglio e con gli studi, certamente più vasti, svolti presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, la Calduch-Benages si cimenta nella scomposizione degli ingredienti di questo sorprendente “profumo” prendendo, per la sua analisi, sei donne, o meglio quattro singole donne, il gruppo della sequela individuato in Lc 8,1-3 e per ultima la figura enigmatica della Sapienza.
Alla base della sua indagine, quasi un elemento comune per la mistura delle varie essenze, l’Autrice propone la definizione dell’ambiente vitale di queste donne e l’esegesi, di cui dimostra piena padronanza, diventa così lo strumento per dare identità a queste figure femminili, che altrimenti rimarrebbero, e finora sono rimaste, immagini sbiadite, soltanto comparse in eventi dei quali, invece, sono assolutamente co-protagoniste insieme a Gesù di Nazaret, il Cristo.
Su questo elemento base (rimaniamo ancora nella metafora del profumo) vengono individuate progressivamente le singole essenze.
Dapprima le note di testa, discrete ma tenaci: l’emorroissa, la donna siro-fenicia, il gruppo delle donne alla sequela. Donne che non sanno chiedere, donne in silenzio, donne che chiedono insistentemente, donne che, comunque ricevono, ma che, anche, in qualche modo, danno: un gesto di estrema fiducia, una risposta audace fino all’insolenza, l’aiuto sodale. Il profumo della Calduch-Benages diventa così quello proprio del Vangelo, della Buona Novella: non è solo il male fisico quello da cui vengono liberate, ma anche e soprattutto il male spirituale, perché la sofferenza del corpo, nell’integralità della persona umana, mai è disgiunta dalla sofferenza psicologica e sociale e la “guarigione” pertanto diventa il luogo della propria ritrovata verità, conseguenza dell’azione salvifica di Colui che si autodefinirà la Verità.
Le note di cuore, quasi uno stordimento dei sensi, sono date da due veri profumi, quello della sconosciuta di Lc 7,36-50 e il nardo, copiosissimo, di Maria di Betania, entrambi versati sul corpo di Gesù. La prima, la sconosciuta, nella sua gestualità d’amore, così straordinariamente fisica, ritrova la propria integrità da parte di Colui che è Amore; la seconda, Maria, dà compimento all’immagine di colei che si è scelta la parte migliore (Lc 10,42) nel gesto profetico dell’unzione, non di un corpo destinato alla morte, ma del Risorto, del Vivente, poichè «…la fragranza del profumo (Gv 12,3) di Betania è simbolo della vittoria di Cristo sulla morte» (cfr p.105).
La nota finale, quella destinata a lasciare la scia, a permanere, dopo la dissolvenza delle altre, è il profumo, oseremmo dire, mistico della Sapienza, figura enigmatica, la cui presenza appare in filigrana fin dalle prime pagine dell’Antico (o Primo, come anche l’Autrice, a volte, ama chiamarlo) Testamento, per poi definirsi, nel prosieguo degli scritti veterotestamentari, sempre più compiutamente come figura di donna, o meglio di gentildonna con caratteristiche specifiche, che l’Autrice riporta con dovizia di citazioni. E Gesù di Nazaret, il Cristo, il Logos, Colui che «…era in principio presso Dio:/tutto è stato fatto per mezzo di lui…» (Gv 1,2-3a) si lascia avvolgere e permeare da questo “profumo” fino a che questo, infine, diventa la Sua stessa essenza.
Possiamo concludere così queste poche, sintetiche, ma entusiastiche riflessioni, elaborate per dare il gusto di un minimo assaggio dell’opera molto più capillare della Calduch-Benages; opera che possiamo definire una lettura altra, perché una lettura di donna sulla realtà di donne e sul rapporto particolarissimo di queste con Gesù di Nazaret, il Cristo. Una lettura senza inutili enfasi, senza scomode rivendicazioni, ma portata avanti con il rigore, potremmo dire, scientifico, dell’esegeta e biblista di classe, che non opprime e dimentica, però, la passionalità della donna e della credente; un percorso interiore, giocato sulla suggestione di incontri salvifici e rivelatori.
Anna Talini