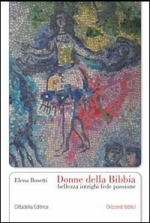Chiunque conosca Elena Bosetti conosce anche il suo sorrisosereno, la voce tenuta su toni pacati,nonostante “il microfonoincorporato”, la sua commozione quandoraggiunge l’acme nel parlare di Dio e sa che, ad un certo punto, nel mezzodelle sue lezioni o delle sue relazioni, portate avanti sempre, apparentemente,sul filo del già detto, quasi dell’ovvio, vi è un qualcosa, una frase, a voltemeno, una parola, un sentore come di sovvertimento, che ti coglie impreparato, ma non ti impaurisce edinvece ti suscita stupore e ti invoglia a cercare meglio da dove venga quellanovità e dove possa portare, facendoti riconsiderare l’apparentementeovvio.
Chi la conosce puòritrovarla appieno, e chi non la conosce trovarla, nel suo ultimo libro DONNEDELLA BIBBIA bellezza intrighi fede passione…, Cittadella Editrice, Assisi,2009. Ed è proprio in questo che consiste l’apparentemente ovvio: ancora donne,ancora donne della Bibbia e ancora dette da una donna, come se non fosserosufficienti tutti i testi precedenti, sull’argomento. Eppure, proprio in questaapparente ovvietà, Bosetti sa trovare, ancora una volta, elementi sconosciuti,se non addirittura dirompenti. Cerchiamo, quindi, come in un crescendo, dienunciarne almeno tre.
Primo elemento, che potremmodire di carattere metodologico: come i veri adoratori del Padre, i quali sanno che lo Spirito soffia dove vuole, anche al di là deititoli accademici e delle pubblicazioni accreditate, e, di conseguenza,sono consapevoli che parole di sapienzae verità si possono ritrovare anche in persone e testi fuori del più ristrettoambito accademico e editoriale, Bosetti, oltre alla bibliografia ponderosa,soprattutto per importanza degli autori, cita, nel corpo del testo, anche unatesi (cfr pagg. 66, 67, 68, 70) di Magistero di Scienze Religiose presso la Pontificia UniversitàGregoriana.. Ed in effetti, una sceltainusuale ed un argomento anch’esso poco frequentato,persino dalle tante teologhe che si occupano delle donne bibliche: la figura diSusanna (cfr Dn 13).
Secondo elemento, decisamente di carattere antropologico:le donne della Bibbia sono donne incammino. Sotto questo aspetto, tra lealtre e, certamente, al di sopra ditutte le altre, ritroviamo Miriam, meglio conosciuta come Maria, di Nazaret(cfr pag. 90 e seguenti). L’iconografia ufficiale, peraltro stupenda, cipresenta la Madredi Gesù come imprigionata in una fissità che, di fatto, non è conforme alla Suafigura, secondo quanto ci è tramandato dagli Evangelisti, che parlano di Lei.Infatti, di solito Maria è raffigurata come bloccata all’annuncio dell’Angelo(basti pensare alla stupenda Annunziata di Antonello da Messina) oppureparimenti bloccata, ai piedi della Croce, statua di dolore senza pari, quasiuna replica della moglie di Lot, resa di pietra, però, non dalla visione dellagiustizia di Dio, ma dalla contemplazione terrificante della incommensurabilemalvagità umana. Maria è questo, ma piùgenuinamente è una donna in cammino: basti pensare alla visita alla parenteElisabetta, come, di fatto, cita Bosetti. In seguito, però, nei Vangeli, Lavediamo ancora in cammino: verso Betlemme e dopo in fuga verso l’Egitto e poial ritorno, ma soprattutto, ed è questo un luogo teologico che andrebbe esplorato, il suo peregrinare sempre allacontinua ricerca del Figlio e della Sua identità e sempre a Gerusalemme sia perla circoncisione che in occasione dei Suoi dodici anni ed infine per la Sua morte e nel mezzo, quasisempre dimenticata, quella insolita sortita insieme ai vari parenti e di nuovoalla Sua ricerca. E se le donne biblichesono donne in cammino, sono anche donne che incitano al cammino e, su tutte,paradigmatica la prima Maria biblica (cfr pag. 31 e seguenti), quella anziana,la sorella di Mosè, la prima delle cinque profetesse veterotestamentarie,quella fanciulla di novant’anni che, con energia impensabile e ineguagliabile,balla, canta, suona il timpano e incita le altre donne a ballare e suonare ecantare il ritornello di quel meraviglioso inno che è il canto del mareintonato dal fratello, quel ritornello che è la verace preghiera a Dio, unicovincitore. E tanto è lei a segnare il cammino che, come sottolineasapientemente Bosetti (cfr pag. 35), il popolo e soprattutto la nube dellaGloria si fermano ad aspettarla mentre è costretta, secondo i dettami dellalegge, in isolamento per sette giorni a causa della lebbra.
Infine il terzo elemento, il più significativo, quello di caratterecristologico: « Possiamo cogliere qualche anticipazione del mistero pasquale inchiave femminile?» (cfr pag. 19). È questa una domanda aperta: può Dio,che nelle pagine dell’Antico Testamentosi compiace, a volte, di assumere atteggiamenti materni, aver adombrato la vicendadell’Unigenito incarnato nella storia delledonne, di alcune donne? Intanto una figura di donna: Rachele, «l’unica donnadesignata espressamente con la qualifica di “pastora” (ro‘ah)» (cfr pag. 20). ERachele era bella di forme e avvenente di aspetto (Gen 29,17) e certamente doveva essere anche brava se il padre le aveva affidatole greggi e bello/bravo (buono) è ilPastore (Gv 10,11). L’unica “pastora”della Bibbia e l’unico, vero Pastore, ugualmente belli/bravi.
Rachele, però, è la donna/tomba perché il suo ventre non accoglie la vita; è la donna che preferisce morire pur dinon restare sterile e che alla fine muore proprio nel dare la vita, quella vitatanto desiderata, quel bambino che doveva essere figlio di dolore e che inveceè figlio della destra e quindi di benedizione, di ricchezza, di potenza.
Rachele che assume su di sé il pianto per la morte di tuttii figli di tutte le madri, quei figli che conoscono l’esilio, che è simile allamorte, lei che rifiuta di essere consolata perché non sono più (cfr pag. 22)finalmente sarà consolata da quel Figlio, che doveva essere Figlio di dolore,Uomo dei dolori e che invece è Figlio di benedizione e potenza, il qualesconfiggerà la morte, ritornando dall’esilio della morte, perché Egli è la Vita, quella sorgentezampillante in eterno, come rivelato, peraltro, ad un’altra donna (cfr. pag.124); quel Figlio che è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sonomorti (ICor 15,20), come dirà Paolo, proprio un beniaminita (cfr Ef 3,5). Nellavita di Rachele, in definitiva, suggerisce Bosetti, è tratteggiato quelmovimento tomba/morte/vita che sarà lo stesso movimento dell’evento pasquale.
Anna Talini