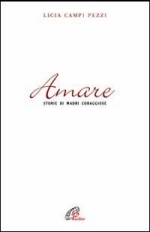AMARE: questo il titolo del libro di Licia Campi Pezzi (Editrice Paoline, pagine 214) scelto dall’Autrice per raccontare, come dice il sottotitolo, Storie di madri coraggiose. Solo un verbo e all’infinito per suggerire, fin dall’inizio l’essenza stessa dell’amore materno: attivo, perché, con l’amore materno, si entra nella dimensione stessa della vita, ed infinito, nella sua dimensione temporale ed affettiva. Più specificamente, l’amore delle madri è infinito nella sua dimensione temporale sia globale, perché le storie delle madri si tramandano da tempi antichissimi, sia individuale, perché è un amore non-finito con i propri figli, ma si prolunga nei nipoti come per Elena (pagg. 23-30), Estela Carlotto e le nonne di Plaza de Mayo (pag.167-186), e, a volte, anche oltre, per i figli delle altre donne come per Cindy Sheaahn (pag. 208), perché in fondo per le donne “erano tutti miei figli”, citando Arthur Miller, drammaturgo ebreo, ed infinito nella sfera affettiva, perché multiforme come molteplici sono le donne e diverse per luogo e tempo le occasioni nelle quali vivono questa loro dimensione.
Questi i binari scelti dall’Autrice e su questi si snoda il suo lungo racconto delle storie di madri coraggiose; un lungo racconto portato avanti con uno stile lineare, ma coinvolgente, frutto certamente del suo impegno lavorativo di collaboratrice a giornali e settimanali oltre che docente, che si rivela nella sapiente scelta delle vicende da individuare, e nel seguire, poi, per ognuna, il criterio della realtà storica, lasciando trapelare, però, come ricchezza ulteriore, il suo coinvolgimento personale di madre.
Una sola piccola annotazione all’asserzione dell’Autrice (pag. 5): definendo pre-cristiana la nostra epoca è sempre bene non dimenticare che il Cristianesimo mai ha disconosciuto il valore, per sé fondante, della storia biblica e il Primo Testamento abbonda di storie di madri e di madri coraggiose, delle quali è erede e compendio sommo Maria di Nazareth, che apre, poi, la storia alle altre madri, che ormai possono essere dette cristiane. Tra queste madri, chiamiamole veterotestamentarie, campeggia la figura di Betsabea, che, nell’immaginario comune, rimane l’ispiratrice del grande delitto di Davide, ma che, di fatto, è la grande regina-madre di Salomone. L’abbiamo voluta ricordare perché a leggere le storie di intrighi e violenze e nefandezze soprattutto di Elena, ma, in qualche misura anche di Adelaide di Borgogna e Bianca di Castiglia (pagg. 39-56), di Beatrice Visconti (pagg. 57-62) e di Maria Carolina du Berry (pagg. 84-94) non si possono non notare le analogie con la sua storia (cfr I Re 1,11-53; 2,17-25). Madri e prima ancora donne del loro tempo e protagoniste di quella più universale storia tracciata da una Provvidenza “che scrive dritto sulle nostre righe storte”.
E come Rachele muore per dare la vita al figlio tanto desiderato, più della sua stessa vita (Gen 30,1.24; 35,16-19), così, volontariamente, hanno anteposto la vita e la salute del figlio, alla propria stessa salute e vita, Gianna Beretta Molla (pagg, 141-159) ed, in tempi più recenti, conducendo la loro personale, e forse inconsapevole, ma non per questo meno esemplare, lotta contro l’imperante e sempre più dilagante cultura della morte, Rita Fedrizzi (pag. 159), Felicita Merati Barzaghi e Carla Levati Ardenghi (pag. 160), Tonia Accardo (pagg. 163-164), mentre per altre come Claudia Cardinali, Soledad e Michelle Stepney (pagg. 162-163) la loro scelta si è conclusa con il trionfo pieno della vita, quella della madre e quella del figlio.
Se poi, la storia cristiana, almeno finora, è stata la storia dell’Occidente, con la quale, di fatto, la stessa Autrice si trova a fare i conti, e questa non può non cominciare con la storia di Roma, allora, forse più nota e certamente ancora più paradigmatica, per le nostre storie di madri, non è la madre di Coriolano, ma Cornelia, la madre dei Gracchi, prototipo e modello di tutte quelle madri che, a volte pur non comprendendole, hanno, però, sempre condiviso, con i fatti o con il silenzio, le scelte politiche dei figli fino a vederne la morte, tragicamente sopravvivendo a loro. In tal senso l’Autrice ricorda Adelaide Cairoli e Amelia Rosselli (pagg. 95-115), Estela Carlotto che giunge a chiedere, dietro forte raccomandazione, visto che la vita le è negata, almeno il corpo della figlia, di cui può solo sfiorare la mano, perché l’accorata pietà del marito le vieta la visione del volto (pag. 173), Genoveffa Cervi e Caterina Govoni (pag. 113) ed infine Felicia Bortolotta, madre di Peppino Impastato (pagg. 203-204).
Se finora, però, le storie delle madri possono essere ricondotte sul filo di una storia, per altri versi già vissuta, anche nell’orrore delle guerra, come per Genny Bibolotti Marsili (pagg. 118-126), l’Autrice ci conduce là dove era impensabile giungere, perché mai nelle vicende umane si è assistito al deliberato e sistematico e intenzionalmente contraffatto sterminio di un intera comunità religiosa, gli ebrei, e di altre minoranze come gli zingari, gli omosessuali e i portatori di handicap; ci conduce là nei campi di sterminio, tra quel fumo incessante (pagg. 117-118; 126-140), quella fatica e quel dolore, dove il coraggio delle madri nulla ha potuto contro una barbarie senza nome e, speravamo, ma la tragedia argentina ci ha disilluso, senza più tempo. Eppure anche in questo orrore indicibile l’Autrice ci svela che qualcosa poteva essere fatto ed è stato fatto solo dalle donne, mogli e madri (pagg. 136-140), come molti anni dopo dalle madri argentine, perché, come dice un adagio, “molto osa, chi ha poco da perdere” e le donne non hanno mai molto da perdere, perché il metro della loro vita sono gli affetti, soprattutto, anche se non solo, i figli.
Alla fine del suo lungo racconto, l’Autrice può iniziare ad incrinare i confini della nostra storia, perché ci fa arrivare oltre le nostre strutture abituali, là dove l’altro, il diverso si impone e ci interroga e noi ci ritroviamo impreparati e sconvolti della sua profonda alterità rispetto alle nostre convenzioni e convinzioni, ma con l’urgenza dell’impossibilità ad ignorarlo, perché è diventato il nostro vicino, il nostro prossimo. È ormai soprattutto l’Islam con il quale ci dobbiamo confrontare ed ecco la storia di Betty Mahamoody, che tenta e riesce a strappare la figlia ad una vita inconcepibile per una donna occidentale, ed ancora la storia di Safiya, condannata alla lapidazione, ma salvata perché la comunità internazionale le ha dato la possibilità non di salvarsi, ma solo, semplicemente, di difendersi.
Infine è bene terminare là dove, invece, per ragioni cronologiche l’Autrice inizia, con la storia di Perpetua e Felicita (pagg. 9-22). Due martiri cristiane, martiri nel senso pieno della parola, perché hanno portato a compimento la loro testimonianza di fede accettando la morte, peraltro orribile, pur consapevoli che l’abiura avrebbero loro restituito, con la vita, i bambini, appena nati. Coraggiose non perché madri, perché, anzi, la recente maternità le avrebbe dovute debilitare sia fisicamente che spiritualmente, ma coraggiose nonostante la maternità ed è questo il monito che ci dovrebbe interpellare ancora oggi, in questo momento attuale, in cui, nonostante la buona volontà di molti, la confusione è molta e, inconsciamente, si tende ad assolutizzare il relativo: l’amore materno è un grande sentimento, ma, parafrasando il titolo di un testo del femminismo, è “un amore in più”, e l’unico e profondo amore della nostra esistenza, come il Figlio stesso esige (Mt 10,37; Lc 14,25), deve essere rivolto a Dio, che poi è il Padre/Madre per eccellenza. Ed ecco che allora la piccola Perpetua può affermare “ E fui fatta maschio” ricomponendo quell’immagine originale dell’unidualità genesiaca a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.
Anna Talini