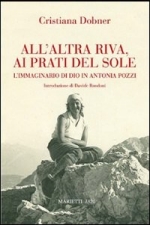Ai pozzi, ai lavatoi, nelle piazzette di paese, sullepanchine dei giardini pubblici e, per le più ricche, nei salotti: sempre ledonne si sono cercate e si sono incontrate per narrare le loro storie e perparlare della loro storia. Cristiana Dobner non rifugge da questa abitudine, quasi un rituale femminile, e locontinua, ma in modo del tutto personale; cerca le donne (María Zambrano,Diotima Teresa di Lisieux), va loro incontro ed intesse sulla loro storia deilibri del tutto particolari. L’ultima di queste non-biografie è incentratasulla vita di Antonia Pozzi.
Il “mondo”, con la sua necessità di mettere etichetterassicuranti, definisce Antonia Pozzi una poetessa, ma poeti sono coloro che,in qualche modo, divulgano le loro opere ed, invece, le poesie della Pozzi sonostate pubblicate postume, non dovevano essere stampate (cfr. pag. 111): per lei«la poesia è una catarsi del dolore, come l’immensità della morte è una catarsidella vita» (cfr pag. 116) e come non condivise la morte così, in vita, noncondivise le sue poesie. E lo stesso “mondo” dimentica che aveva conseguitobrillantemente la laurea in filosofia, quando l’Università per le donne, anchedi buona famiglia, non era del tutto usuale; aveva viaggiato e fatto sport –anche questi fatti abbastanza inusuali per una donna dei primi del Novecento -,amava anche la fotografia, aveva insegnato ed infine, in qualche modo, si eraimpegnata nel sociale e tutto nel breve arco di ventisei anni. Dunque unafigura, o meglio, una persona, polivalente, ma forse soltanto e semplicementeuna donna; semplicemente per quanto possa esserlo, in definitiva, una donna eogni donna.
Ed è di una donna che la Dobner parla o, meglio, è una donna che l’Autricelascia parlare (virtù attualmente assai rara), attraverso le poesie di questa eservendosi, invece, dei suoi interventi personali, per lo più, solo come unmezzo per unire tra loro questi stralcidi sofferenza, ricomponendo l’unità di un’anima tormentata, come un’abileartigiana, con un’arte dimenticata, tesse una trina, che unisca piccolicapolavori per un’ unica, finale e piùcompleta opera d’arte. Infatti così la Dobner definisce se stessa “mi ritengo moltosimile ai cavatori…” (cfr. Introduzione pag. 5) ed è per questo che “cava” enon “scava”e in questo suo lavorio, cheha il senso di altri tempi e di altre braccia, si serve non solo delle sueforze e di quelle di Antonia, ma ricorre anche ad altri mezzi, come altrelingue ed altre immagini, quando sente la strettezze dell’italiano, e soprattuttoricorre all’altro, all’uomo, al maschio,- specialmente Eugenio Borgna - aldiverso, perché solo così, allontanandosi dal sé, guardandosi come al di fuori,si riesce ad avere l’immagine dell’io. Operazione, invece, che non era riuscita alla Pozzi , la quale, piano piano,“gheriglio essiccato nel suo guscio” si era cibata di sé e del proprio dolorein un autocannibalismo che l’ha portata, inevitabilmente, all’autodistruzione.
L’autodistruzione e ultimamente il suicidio: è questo l’epilogodella storia di Antonia Pozzi; materia, in qualche modo, ambigua da trattare,soprattutto perché il definitivo turbamento devastante, in un’anima giàoltremodo fragile, era stato originato da un amore impossibile, non tantoperché non corrisposto, ma perché «nell’amore …Antonia non riesce a compiere unesodo dalla terra abitata dall’infanzia…Non riesce a crescere con radici autonome…» (cfr. pag.100); materia ambigua, non tanto dal punto di vista morale o moralistico (e diquesto la Dobnernon si deve essere preoccupata, si è decisa per questo incontro), ma proprioper il possibile, e magistralmente evitato, pericolo di decadere nel romanzesco di bassa legaoppure in una sorta di irrispettoso percorso psicologico, morbosa descrizionedel crescendo di una tristezza fino all’implosione finale. Dunque non unromanzo, non una biografia, non una rivisitazione psicologica, qualcosa d’altroo forse una calibrata mistura del tutto, redatta con uno stile personalissimo ed accattivante, erudito, maappassionato che irretisce il lettore e lo trascina a consumare le pagine,instancabilmente fino alla conclusione, peraltro già anticipata nella presentazionedel testo. Perché Cristiana Dobner èattenta a seguire il percorso vitale di una persona, non di un “caso”.
Antonia Pozzi, dunque, una donna, semplicemente una donna che ha vissuto le contraddizioni che, generalmente, l’esseredonna, nel secolo appena passato e in questi pochissimi anni dell’attuale,porta con sé, senza riuscire, però, a risolverle: il desiderio, da lei“borghesemente” vissuto, di un amore o meglio di una famiglia el’autoaffermazione come persona (lo sport, la laurea, il lavoro). Appenatrent’anni dopo la sua morte (nel 1968, appunto) i giovani della sua età e dellasua condizione sociale avrebbero trovato la forza di gridare quelleirrequietudini, in cui lei era rimasta imbrigliata, e, ancora pochi anni dopo,le donne avrebbero cominciato a cercare, con una fatica di cui ancora adessoportiamo il peso e la speranza, la loro dimensione di persona, nel proprio orizzontefemminile.
Cosa, allora, è mancato ad Antonia? La Dobner, a questo punto,esce dal suo riserbo e dà la sua risposta, quella del credente, che vedeun’anima ferita, la quale, pure, come in un sussulto nell’ora del doloreestremo, aveva rivolto la sua preghiera a Dio, naufragare, invece, nellapropria tristezza «…senza aver intravisto la mano di Dio tesa, come inveceavvenne nella vicenda storica di Edith Stein» (cfr. pag. 115); il credenteche percepisce che «La grazia di Diosembra non aver condotto Antonia…alla conversione; l’unico atteggiamento …èquello di accettare la realtà, con una mossa ulteriore per chi è credente:consegnare il mistero di un’anima a Chi,solo, può capirla ed amarla»(cfr. pag. 107).
Ed allora Cristiana Dobner, donna, credente, carmelitana e teologa, ci mette davanti al suicidiodi Antonia, ma non davanti alla parola fine della sua vicenda, perché la morte, per noi cristiani, non hal’ultima parola e, nel lasciarla, sceglie come viatico, in tanto dolore, unlampo vitale. Non siamo qui alla ricerca entusiastica e banale dell’happy endcinematografico, ma davanti all’Oltre, davanti alla, per noi, sconcertante Misericordia:Antonia, che amava la montagna, luogo privilegiato della teofania di Dio e delcredente alla Sua ricerca, non riesce in essa a trovarLo, ma si lascia morirein una pianura a pochi metri dall’Abbazia di Chiaravalle; nessuno, allora, cipuò impedire di immaginare, ma soprattutto di credere che «Dal suo tempio haudito la mia voce / il mio grido è giunto al Suo orecchio.» (Sal 18,7) e«Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro…»(Lc 15, 20) per portare, finalmente, quell’anima raggelata, quel “gheriglioessiccato” «all’altra riva,/ ai prati del sole».
Anna Talini