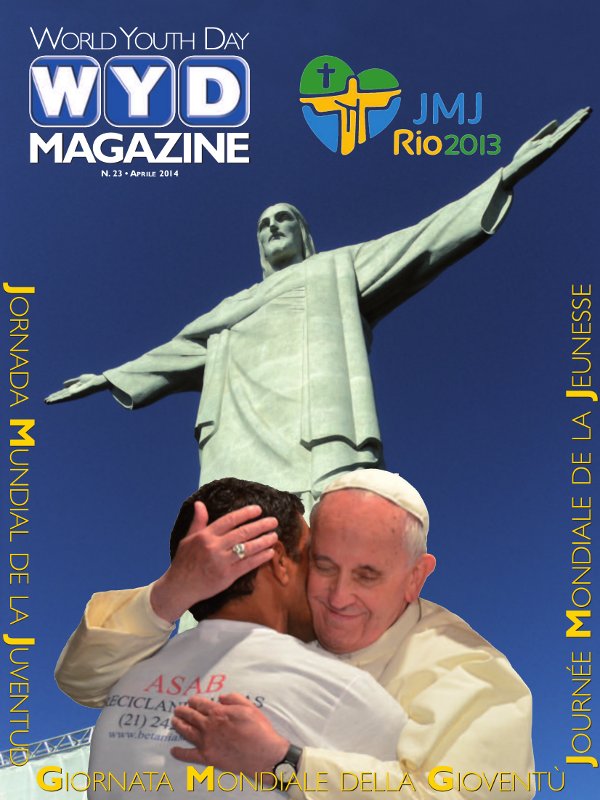Siccome la mia responsabilità nel Pontificio Consiglio per i Laici consiste sia nell’accompagnamento della preparazione delle Giornate Mondiali della Gioventù (GMG), sia nella riflessione sulla pastorale giovanile, il mio intervento verterà su due aspetti:
1. come contribuiscono le GMG alla maturazione delle vocazioni?
2. come impostare la pastorale giovanile affinché sia favorita la nascita di vocazioni?
La GMG è un luogo fecondo di appello vocazionale
Di ritorno dalla GMG di Colonia, Benedetto XVI disse:
Vorrei qui rievocare un incontro singolare, quello con i seminaristi, giovani chiamati a una più radicale sequela di Cristo, Maestro e Pastore. Avevo voluto che ci fosse un momento specifico dedicato a loro, anche per mettere in risalto la dimensione vocazionale tipica delle Giornate Mondiali della Gioventù. Non poche vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata sono sbocciate, in questi venti anni, proprio durante le Giornate Mondiali della Gioventù, occasioni privilegiate nelle quali lo Spirito Santo fa sentire la sua chiamata. (Udienza Generale del 24 agosto 2005).
In effetti sappiamo per esperienza che le GMG, al di là del fantastico dinamismo pastorale che hanno generato, hanno grandemente contribuito al risveglio delle vocazioni sacerdotali e religiose. Un sondaggio in un seminario di un paese che abbia accolto una GMG può dimostrarlo rapidamente.
Come mai le GMG apportano un contributo prezioso nell’ambito delle vocazioni? Le ragioni sono molteplici.
Fondamentalmente la GMG è una epifania di Dio e della Chiesa. Giovanni Paolo II definiva la GMG come un tempo di incontro con Cristo. Tutto il progetto pastorale della GMG è orientato verso questo incontro, attraverso le catechesi, le celebrazioni eucaristiche, l’invito al sacramento della riconciliazione, l’adorazione eucaristica e i contatti tra giovani di diversi paesi, in un clima di gioia e di comunione. E questo evento non è un “fuoco di paglia”, come spesso si è temuto, perché si situa nel cuore di un pellegrinaggio che comincia con la preparazione spirituale nell’anno precedente alla GMG (con l’aiuto del Messaggio del Santo Padre che i gruppi sono invitati a meditare), per poi proseguire con le giornate nelle diocesi prima dell’incontro nella grande metropoli. E la GMG termina con un invio in missione. Proprio come i discepoli di Emmaus quando incontrarono Gesù, i giovani possono incontrare il Risorto e tornare a casa per unirsi a una comunità cristiana e rendere testimonianza. Conosciamo l’impatto delle GMG: esse costituiscono un grande stimolo per i gruppi giovanili (nelle scuole cattoliche, nei movimenti e nelle parrocchie), dandogli un nuovo slancio dopo l’evento.
Vorrei sottolineare due aspetti particolarmente significativi dell’esperienza spirituale fondante fatta da tanti giovani durante le GMG. Da qualche anno (soprattutto a partire da Colonia 2005), l’adorazione eucaristica prende sempre più spazio nel programma, su richiesta di tantissimi giovani che si definiscono, essi stessi, come una “generazione eucaristica”. D’altra parte, le confessioni hanno un “successo” sorprendente. I giovani fanno l’esperienza di essere amati da Colui che si rende presente mediante il suo sacrificio eucaristico e di essere salvati mediante il suo perdono. Questi sono due fondamenti di ogni vita cristiana, ma anche di ogni vocazione: i sacerdoti e i consacrati non sono forse testimoni della Misericordia e degli strumenti della salvezza?
In questo, la GMG risulta essere profondamente incentrata sul mistero pasquale. Così il simbolo della GMG è la Croce che Giovanni Paolo II ha donato ai giovani alla fine dell’Anno Santo della Redenzione 1983-1984. Questa Croce prepara la GMG recandosi in pellegrinaggio in tutti i paesi che ospitano l’evento, per poi essere al centro delle celebrazioni, in particolare della Via Crucis del venerdì. Nella sua rilettura della GMG di Sydney, Benedetto XVI sottolineava:
Anzitutto è importante tener conto del fatto che le Giornate Mondiali della Gioventù non consistono soltanto in quell’unica settimana in cui si rendono pubblicamente visibili al mondo. C’è un lungo cammino esteriore ed interiore che conduce ad esse. La Croce, accompagnata dall’immagine della Madre del Signore, fa un pellegrinaggio attraverso i Paesi. […] Le Giornate solenni sono soltanto il culmine di un lungo cammino, col quale si va incontro gli uni agli altri e insieme si va incontro a Cristo. In Australia non per caso la lunga Via Crucis attraverso la città è diventata l’evento culminante di quelle giornate. Essa riassumeva ancora una volta tutto ciò che era accaduto negli anni precedenti ed indicava Colui che riunisce insieme tutti noi: quel Dio che ci ama sino alla Croce. (Discorso alla Curia romana, 22 dicembre 2008).
È noto lo stretto legame tra la vocazione sacerdotale e il mistero della Croce. Poiché la Croce è al centro della proposta pastorale, non c’è da stupirsi che ne nascano delle vocazioni pastorali. Alcuni giovani preti testimoniano anche l’importanza della Croce delle GMG nel loro itinerario vocazionale. Si può dire che alcune vocazioni sono nate ai piedi della Croce.
Un altro aspetto della GMG contribuisce alla sua dimensione vocazionale: la dimensione del servizio. L’organizzazione della GMG si basa soprattutto sull’impegno di giovani che si fanno carico di una parte di responsabilità. Sono i giovani responsabili nelle diocesi e nei movimenti. Sono i volontari che trascorrono settimane o mesi nella città della GMG per dedicarsi all’accoglienza, la pianificazione, la sicurezza, le traduzioni, la liturgia. A Madrid c’erano 22.500 volontari di diversi paesi. Questa responsabilizzazione dei giovani che donano un po’ del loro tempo alla Chiesa, evidentemente costituisce un forte richiamo.
In questo contesto, il Papa e i vescovi fanno risuonare un esplicito appello vocazionale. A Madrid il Santo Padre aveva intenzione di rilanciarlo durante la Veglia. Il suo testo – non pronunciato a causa della tempesta, ma che i giovani hanno potuto leggere in seguito – diceva:
Molti sono chiamati dal Signore al matrimonio, nel quale un uomo e una donna, formando una sola carne (cfr Gn 2,24), si realizzano in una profonda vita di comunione. […] Cristo chiama altri, invece, a seguirlo più da vicino nel sacerdozio e nella vita consacrata. Che bello è sapere che Gesù ti cerca, fissa il suo sguardo su di te, e con la sua voce inconfondibile dice anche a te: «Seguimi!» (cfr Mc 2,14). (Discorso previsto per la Veglia a Cuatro Vientos, sabato 20 agosto 2011).
E Benedetto XVI si è rivolto in termini assai espliciti ai volontari, certamente molto aperti a questa domanda dato il servizio effettuato:
Nel tornare ora alla vostra vita ordinaria, vi incoraggio a conservare nel vostro cuore questa gioiosa esperienza e a crescere ogni giorno di più nel dono di voi stessi a Dio e agli uomini. E’ possibile che in molti di voi si sia manifestata timida o con forza una domanda molto semplice: Che cosa vuole Dio da me? Qual è il suo disegno sulla mia vita? Cristo mi chiama a seguirlo più da vicino? Non potrei spendere tutta la mia vita nella missione di annunciare al mondo la grandezza del suo amore attraverso il sacerdozio, la vita consacrata o il matrimonio? Se è sorta questa inquietudine, lasciatevi guidare dal Signore e offritevi volontariamente al servizio di Colui che «non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10,45). La vostra vita raggiungerà una pienezza insospettata. (Discorso ai volontari, domenica 21 agosto 2011).
Un altro grande motivo per cui la GMG è occasione di risveglio particolare delle vocazioni, è la manifestazione della bellezza della Chiesa a cui abbiamo accennato all’inizio. Molti sono i giovani che ne restano colpiti, soprattutto quelli che vivono isolati. E in questa Chiesa di cui scoprono la bellezza, incontrano molti giovani preti e molte giovani consacrate che vivono con gioia la loro vocazione. Si sa quanto sono importanti questi incontri affinché, attraverso un processo di identificazione, i giovani chiamati da Dio possano compiere il passo di una risposta concreta. In particolare, il contatto pastorale così privilegiato con dei giovani preti lungo tutto il cammino della GMG – nei viaggi in pullman, nelle ore di attesa, durante i pasti – è sicuramente una concreta risorsa vocazionale. In questo contesto, come il Papa, anche i sacerdoti possono porre esplicitamente questa questione.
La pastorale giovanile e l’appello vocazionale
Adesso qualche breve parola sull’appello vocazionale nel quadro della pastorale giovanile. Numerosi pastori sono ben consapevoli che l’appello vocazionale deve essere fatto soprattutto dai responsabili di pastorale giovanile, nelle scuole, nelle università, nelle parrocchie e nei movimenti. Molte diocesi hanno anche unificato il servizio di pastorale giovanile e quello vocazionale. La questione è di sapere che tipo di pastorale giovanile possa far emergere le vocazioni sacerdotali e religiose.
Non si può non constatare che le vocazioni sono particolarmente attratte dagli ambienti ecclesiali con una forte proposta spirituale, comunitaria e missionaria. Facendo un’analisi più approfondita, ci si accorge che i giovani progrediscono nella loro relazione con Cristo se crescono simultaneamente in tre direzioni, che sono i tre pilastri della pastorale giovanile: la vita fraterna, la preghiera e la missione.
La vita fraterna è la relazione con altri cristiani, fatta di amicizia, di preghiera, di testimonianza reciproca e di condivisione della fede, di missioni comuni. Si traduce nella partecipazione a un gruppo di giovani che si riuniscono frequentemente per sperimentare la comunione, essenziale per la vita cristiana e al servizio della quale si pone ogni vocazione.
La vita di preghiera è costituita da tempi di preghiera comunitaria (lode, ascolto della Parola di Dio, intercessione, adorazione eucaristica), tempi di celebrazione dei sacramenti (Eucaristia, sacramento della riconciliazione), tempi di preghiera personale quotidiana (10 minuti al giorno). Nei sacramenti del battesimo e della riconciliazione, i giovani sono invitati a fare l’esperienza centrale della salvezza, chiave della vita cristiana e della vocazione.
La dimensione missionaria ha diversi aspetti: il servizio al prossimo (accoglienza e servizio mensa per persone senzatetto, assistenza ai malati, visita dei carcerati), annuncio esplicito di Cristo (evangelizzazione di strada, catechismo per i bambini), servizio ecclesiale (animazione di gruppi, animazione liturgica, volontariato alle GMG e ai luoghi di pellegrinaggio, responsabilità varie). Si tratta in questo modo di aprire i giovani alla diaconia e alla martyria, essenziali per la vita cristiana e per tutte le vocazioni.
In ogni campo, è necessario offrire ai giovani un cammino progressivo. La partecipazione a un gruppo regolare avviene dopo un periodo di ambientamento, dopo una serie di incontri. L’ingresso nella preghiera personale è graduale, dopo dei momenti forti in cui si sperimenta la presenza di Cristo e l’ascolto della sua Parola. Al servizio si arriva per gradi, acquisendo la capacità di assumere piccole responsabilità. L’annuncio esplicito si sperimenta a poco a poco. E tutto è legato: per esempio, l’annuncio esplicito della fede è sostenuto dalla vita fraterna e dalla preghiera. Questa evangelizzazione fa crescere la fede e stimola la preghiera.
Perciò i giovani hanno bisogno di essere accompagnati personalmente per scoprire come possono progredire a ciascun livello, prendere da soli delle piccole decisioni, ed essere aiutati e incoraggiati nella fedeltà a queste decisioni. Qui intervengono l’accompagnamento personale e la direzione spirituale spesso assicurati da sacerdoti e consacrati, creando un ambito di reale apertura alla questione della vocazione. I giovani hanno anche bisogno di ricevere formazione in diversi aspetti: vita fraterna, fede e preghiera, servizio ed evangelizzazione. Questa formazione è una catechesi articolata che dona intelligenza della fede, richiama alla coerenza dei diversi aspetti della propria esistenza e risponde agli interrogativi posti dalla vita, dal mondo e dalla cultura.
Questa dinamica pastorale, fondata su queste tre dimensioni – fraterna, spirituale e missionaria –, permette effettivamente la nascita di vocazioni. Per mettersi in cammino alla sequela di Cristo, lasciando tutto per lui, il giovane deve aver imparato a riconoscere che Dio gli parla e deve aver cercato con fiducia di fare ciò che Dio gli propone. Allo stesso modo, colui che ha imparato a servire i suoi fratelli saprà rinunciare alle proprie aspirazioni immediate. Colui che avrà sperimentato la necessità e la gioia dell’evangelizzazione, sarà pronto a un’eventuale chiamata di Cristo. E colui che è sostenuto da una comunità in cui ciascuno desidera rispondere alla chiamata di Dio, è portato a porsi “naturalmente” la questione della propria vocazione. E se incontra dei sacerdoti e dei consacrati che sono felici di esserlo, può trovare la risposta con molta più facilità.
Bisogna anche menzionare le proposte di formazione a tempo pieno e di volontariato che vengono fatte ai giovani cristiani: scuole di formazione spirituale e missionaria per la durata di un intero anno scolastico (cosiddette “scuole di evangelizzazione”), periodi di collaborazione di un anno o due al servizio di una Chiesa locale. Queste proposte, che offrono l’occasione di fare una sosta e mettersi a disposizione, vanno incoraggiate. Tutti i giovani cattolici tra i 18 e i 25 anni dovrebbero dare sei mesi, un anno o due del loro tempo, come fanno i Mormoni e altri gruppi religiosi. Questo costituisce per loro un intenso periodo di formazione, li apre al mondo, sviluppa la loro generosità e li inserisce in una logica di servizio. E si sa che questi anni contribuiscono alla maturazione di vocazioni sacerdotali e religiose. Lo stesso succede anche con esperienze più brevi (qualche settimana) di volontariato al servizio della Chiesa o dei più poveri.
I giovani cattolici sono generosi. Chiediamogli tanto e diamogli fiducia, sull’esempio di Giovanni Paolo II, grande suscitatore di vocazioni davanti all’Eterno. In questo spirito, mi si permetterà di citare un educatore gesuita sudamericano, padre Tomas Morales: “Se tu chiedi tanto ai giovani, danno ancora di più. Se gli chiedi poco, non danno nulla”.
Per concludere, vorrei aggiungere questo: proporre ai giovani di porsi la questione della vocazione non fa parte di una “strategia di reclutamento”, ma di una vera pedagogia pastorale. Infatti porre la questione di una chiamata a dare tutto per seguire il Signore, significa offrire a un giovane l’occasione di compiere una tappa esistenziale e decisiva nel suo cammino di fede in Gesù Cristo, che si basa su due punti fondamentali per ogni vita cristiana e per ogni vocazione: credere che Gesù è veramente il buon pastore, che ha un progetto per lui perché lo ama personalmente, e credere anche che il Salvatore del mondo vuole far partecipare le persone alla sua opera di salvezza.
(Testimonianza di P. Eric Jacquinet Congresso della Pontificia Opera per le Vocazioni Sacerdotali Domus Pacis, Roma, 4 novembre 2011)